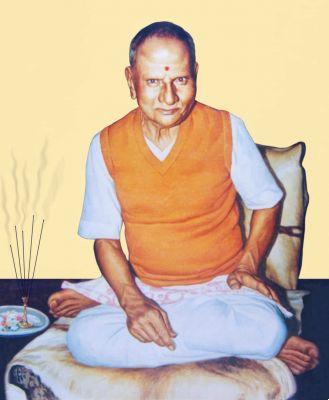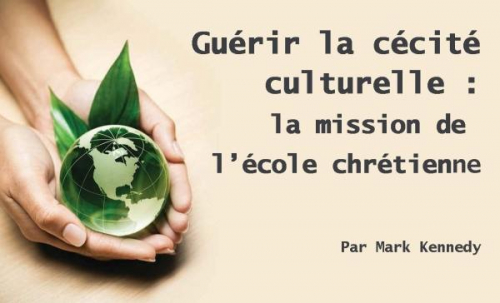“Ora, bhikkhu, questa è la nobile verità della sofferenza: la nascita è sofferenza, l'invecchiamento è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza; dolore, lamento, dolore, angoscia e disperazione sono sofferenza; l'unione con ciò che è spiacevole è sofferenza; la separazione da ciò che è piacevole è sofferenza; non ottenere ciò che vuoi è sofferenza; in breve, stanno soffrendo i cinque aggregati influenzati dall'aggrappamento.
(Samyutta Nikaya LVI.11 – Dhammacakkapavattana Sutta)
Una premessa fondamentale nel Buddismo➀ è che il nostro rapporto con il mondo in cui viviamo, immerso in una realtà condizionata e condizionante, fatta di caducità (anicca) e inconsistenza, genera ogni tipo di sofferenza (dukkha). Questa prima Nobile Verità➁ non vuole spaventarci, né apprezza la possibilità di disperare di fronte al fatto. Ci rivela la situazione. Fuori dalla logica dei concetti che creano una percezione limitata della natura delle cose, delle persone e del mondo stesso; non si sarebbe più nei domini di dukkha. Non si agirebbe più nella motivazione del desiderio, del desiderio o dell'ambizione (tanha), e tutta l'insoddisfazione (dukkha) ci apparirebbe come abiti della nostra infanzia, per i quali manteniamo un affetto speciale, ma anche un'assoluta comprensione che lo fanno non servirci la maggior parte.
Considerata come una filosofia, la sottile impressione del Buddha Shakyamuni può sembrare impraticabile. Se guardiamo alla realtà virtuale che abbiamo creato, in cui siamo momentaneamente ingabbiati, vedremo che non è difficile trovare chi crede piamente in verità intoccabili che si difendono anche con l'uso dell'aggressività, del pregiudizio e di tanto dolore. E quando queste verità non esprimono esattamente l'essenza di ciò che siamo, nell'unità? Siamo abituati a credere e prendere molto sul serio ciò che riteniamo giusto, senza che nessuno, nemmeno noi stessi, abbia alcuna garanzia che questo diritto riduca davvero la sofferenza. Oppure vivere senza soffrire non sarebbe la ricerca più sensata che potremmo intraprendere in questa vita, che è impermanente come tutti i fenomeni?
La verità è che c'è un pezzo molto più fuori posto in questo puzzle, che è difficile da trovare. Siamo concentrati sullo stimolo-risposta. Uno spettacolo di routine che ci fa credere di avere non solo verità, ma anche bellezza, possesso, felicità, ecc. Un'illusione, infatti, che insieme ad essa porta l'identificazione con qualcosa che consideriamo un sé. Ecco la radice del problema. Se sono vuoto e tutti gli avvenimenti sono vuoti, che senso ha cercare di aggrapparsi a qualcosa? Non sembra una perdita di tempo continuare in questo tanha ciranda. Questo è ciò di cui parlava Buddha; e la risposta fondamentale che diede a questo ciclo non avrebbe potuto essere diversa dagli altri saggi che comprendevano la natura dei fenomeni: il distacco (vairagya).
Nel Vedanta, vairagya è la pratica principale attraverso la quale è possibile realizzare una comprensione completa e raggiungere alti livelli di elevazione spirituale. Sivananda, riconosciuto swami, spiega che vairagya nasce da viveka, cioè dalla discriminazione tra eterno e non eterno (nitya e anitya), reale e non reale (sat e asat) ed essenza e non essenza (tattwa e atatwa). . Propone inoltre che la devozione (aradhana) e l'altruismo praticati in vite diverse ci portino a viveka➂. In ogni caso, anche la concezione indù cerca ancora un'identificazione, qualcosa di separato da noi e che otterremo con il nostro sforzo.
Ciò che Buddha propone è, come lo chiama lui, "andare controcorrente", elevandoci alla comprensione che l'essenza primordiale non esiste, come un'anima, un Sé o uno spirito separati; e che, al di là dell'ego e della personalità, siamo coscienza libera, non-sé (anatta➃). La sottile apprensione di Shakyamuni invade le profondità dei nostri sentimenti e sensi e disturba il corollario della nostra esistenza. Ciò che il meditatore suggerisce è che entriamo anche nella meditazione profonda (samadhi), per assistere alla smaterializzazione della bolla della nostra esistenza mentre si tuffa nell'oceano della comprensione. Il fatto è che suonerebbe brevemente contraddittorio un argomento che eleva l'anicca come verità per dare, allo stesso tempo, la possibilità di un sé permanente; sebbene questa non fosse la preoccupazione fondamentale del Buddha, che si preoccupava principalmente dell'estinzione dell'ignoranza di innumerevoli esseri in un modo più semplice e chiaro.
Krishnamurti, filosofo e libero pensatore indiano, credeva nel potenziale umano di comprendere l'anatta e sosteneva che siamo in grado di raggiungere ciò che lui chiamava pensiero creativo, cioè la felicità come risultato della pura osservazione della realtà e della non dualità nel discernimento. la natura delle cose. Questa idea è alla base della concezione buddista del non sé, poiché, lasciando andare concetti e pregiudizi, l'essere umano si libera naturalmente anche dall'idea di un sé.
La potenza creativa sorge quando siamo liberi dalla schiavitù della brama, con i suoi conflitti e le sue sofferenze. Attraverso l'abbandono dell'io, con la sua positività e crudeltà, con le sue incessanti lotte per divenire, sorge la Realtà creatrice. Nella bellezza di un tramonto o di una notte serena, non hai già provato una gioia intensa e creativa? In un tale momento, essendo l'io temporaneamente assente, sei suscettibile, aperto alla Realtà. Questo è un evento raro, non ricercato, indipendente dalla nostra volontà, ma l'"io", dopo averlo gustato una volta, in tutta la sua intensità, vuole continuare a goderne, e così inizia il conflitto.
(Krishnamurti in L'egoismo e il problema della pace, 1949)
Ciò che Krishnamurti descrive sopra sopravvive: una realtà creativa, che è libera dal velo dell'apparenza ordinaria dei fenomeni in cui viviamo. Come esamina il filosofo, in momenti sottili della nostra vita, già assaporiamo questo svuotamento e oblio di sé, che fruttifica l'intimità dell'esperienza e ci guida come esseri su questo pianeta. Cerca solo di ricordare l'estasi vissuta nello splendore del piacere sessuale. O il momento di immersione causato dall'osservazione della bellezza di una farfalla in volo. Il Samadhi, in questo senso, non sembra così irreale, almeno se non siamo tornati rapidamente da queste esperienze al contesto egoistico delle nostre esistenze individuali.
Non è necessario indagare molto a fondo per dedurre che queste esperienze ci mettano direttamente sotto scacco, poiché ci danno una scintilla di cosa sia la vera felicità e ci mostrano quanto superficialmente siamo di fronte al potenziale cosmico che portiamo.
Purtroppo, questa contraddizione che viviamo quotidianamente non è in grado di dissolvere del tutto la nostra identificazione con la realtà sofferente del mondo moderno; anche se viviamo come un albero messo a crescere dentro una scatola di vetro, dove non c'è più spazio. Un sistema che crea una realtà completamente dicotomica e segregante è nel mezzo del fallimento e sta esaurendo l'umanità.
L'ansia generalizzata derivante dall'instabilità di ciò che pensavamo non sarebbe cambiato così rapidamente e drasticamente ha causato conflitti, poiché l'ansia nel corpo genera malattie psicosomatiche. Allo stesso tempo, la capacità di condizionare i desideri nella nostra epoca di consumo rende difficile comprendere l'intero processo di abbandono di sé e la vera felicità che la realtà creativa è in grado di donare all'essere umano. Una possibilità che abbiamo per uscire dall'instabilità e dalla paura ed evolverci come una corsa per il bene comune di tutti gli esseri.
➀ La discussione sulla natura del Buddismo come religione o filosofia è così ampia che è più giusto considerarla qui come una comprensione profonda e sincera della realtà, resa possibile dagli zelanti sforzi di Shakyamuni Buddha.
➁ Il Buddismo riconosce le Quattro Nobili Verità per comprendere la nostra realtà di sofferenza.
➂ Essenza di Vairagya. SIVANANDA, Swami. Traduzione di Nando Pereira per Darmalog. Originale.
➃ Lettura consigliata: Anatta: La dottrina del “non-sé”, di Walpola Rahula.